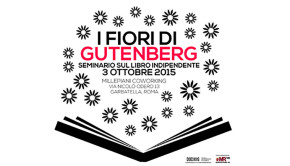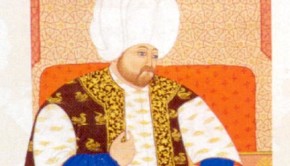Informazione locale, scenari globali
Il moltiplicarsi di media territoriali e indipendenti evidenzia che l’opinione pubblica ha sete di informazione veramente plurale. Mentre in Italia qualcosa si muove a livello regionale, oltreoceano i media comunitari sono protagonisti di rango costituzionale. Core ha intervistato Mauro Cerbino, Decano del Dipartimento di Studi Internazionali e Comunicazione della Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales di Quito, parte attiva nella rivoluzionaria riforma nel settore dell’informazione in Ecuador.
Media comunitari per un territorio ben informato
Le mobilitazioni degli ultimi anni, in diverse parti del mondo, hanno dimostrato come l’informazione orizzontale e dal basso sia un requisito indispensabile per la costruzione delle lotte, la condivisione del sapere e la contaminazione dell’agenda mediatica.
Le rivolte nordafricane del 2011, il 15M spagnolo, l’Onda studentesca italiana e molte altre esperienze hanno in comune, nella loro organizzazione, l’utilizzo di strumenti e canali d’informazione di natura locale e indipendente, dislocati nei territori e sganciati da dinamiche di clientelismo economico-politico proprie di stampa e tv mainstream.
Tra questi media ci sono radio, testate giornalistiche, web tv e piattaforme tecnologiche che, nate a stretto contatto con le pratiche sociali e politiche espressione dell’attivismo territoriale, fanno da cassa di risonanza a valori, notizie e istanze altrimenti assenti nella rappresentazione mediatica dominante, spesso appositamente distorsiva degli eventi.
Tali mezzi di comunicazione, “comunitari” poiché in-comune tra chi li anima e chi ne usufruisce, esistono in funzione della relazione che stabiliscono con le proprie audiences e del processo di partecipazione/appropriazione che rappresentano. Si auto-determinano e, di conseguenza, si auto-gestiscono, assicurando così indipendenza e autonomia al proprio progetto comunicazionale, e facilitando la messa in rete delle vertenze che portano avanti, anche su un piano g-locale.
Proprio in ragione della loro natura indipendente e della loro organizzazione locale e reticolare, i media comunitari costituiscono oggi il presidio migliore a garanzia del pluralismo dell’informazione. Non solo moltiplicano le voci in campo, ma diversificano l’offerta informativa, contribuendo alla formazione di un’opinione pubblica più consapevole ad una partecipazione democratica reale che, partendo dai contesti territoriali di prossimità nei quali i cittadini cominciano a diventare protagonisti, può connettersi con realtà, lotte e vertenze in qualunque altra parte del mondo.
Non stupisce, quindi, che i decisori politici comincino a fare i conti con le potenzialità dei media comunitari. A ben vedere, l’informazione locale in Italia non ha ancora una sua regolazione compiuta né tantomeno un piano di finanziamento adeguato a sostenerla.
Tuttavia, si intravedono alcuni tentativi diretti ad invertire la rotta. La Regione Toscana, al termine di un procedimento legislativo che ha in certa misura coinvolto alcuni stakeholder (gli operatori di rete e di radiodiffusione in Toscana, l’Ordine dei giornalisti e l’Associazione stampa della Toscana), nel 2013 ha stanziato 3 milioni di Euro a sostegno delle imprese di informazione locale. La nuova legge ha riservato interventi di sostegno sulla base del rispetto del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, della regolarità dei versamenti contributivi e del vincolo a svolgere almeno il 70% dell’attività di informazione in Toscana. Per accedere ai finanziamenti, le imprese del settore devono “coprire” il territorio toscano, assumere un certo numero di giornalisti professionisti a tempo indeterminato e versare regolarmente i contributi previdenziali.
Qualcosa di analogo è accaduto anche in Sicilia, dove lo scorso dicembre l’Assemblea regionale ha approvato una nuova legge che sponsorizza l’ammodernamento dei media siciliani, abbattendo gli interessi o prestando garanzia alle eventuali operazioni finanziarie a tal fine attivate dalle imprese d’informazione locale.
Timidi tentativi di riforma che, se da un lato potrebbero attivare un auspicabile effetto-domino in tutte le Regioni d’Italia, dall’altro sono difficilmente in grado scalfire l’impianto normativo nazionale che regola la stampa e il sistema radiotelevisivo. Si tratta infatti di una normativa di settore disorganica che, schiacciata entro la dicotomia pubblico-privato, concede poco spazio alle esperienze d’informazione locale, comunitaria e indipendente.
Proprio per questo vale la pena di guardare oltreoceano. Ecuador e Bolivia, in attuazione delle nuove Costituzioni del 2008-2009, hanno tripartito le frequenze radiotelevisive tra settore privato (33%), pubblico (33%) e comunitario (34%). Le implicazioni della nuova normativa sono innumerevoli e per certi versi rivoluzionarie, anche se i procedimenti legislativi partecipati e controversi, alcuni limiti – non viene considerata la stampa – e contraddizioni ridimensionano la portata di tali riforme.
Core ha intervistato Mauro Cerbino, Decano del Dipartimento di Studi Internazionali e Comunicazione della Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales– sede Ecuador. Cerbino, specialista in studi di Comunicazione, Media e Opinione Pubblica, ha partecipato attivamente all’intero processo di riforma che dalla nuova Costituzione del 2008 ha condotto alla Ley Orgánica del 2013 in Ecuador (segue in Intervista).
Ecuador, rivoluzione costituzionale?
La riforma costituzionale ecuadoriana del 2008 tutela l’informazione e la comunicazione come oggetto di diritti del buen vivir, dunque all’interno di un nuovo modello economico, politico e sociale su cui il Governo Correa ha voluto scommettere per contrastare le politiche neoliberiste. Qual è stato il processo che dal basso ha condotto a questo avanzamento giuridico? Quali sono state le istanze specifiche che hanno prodotto questo risultato? Chi erano gli attori protagonisti di queste rivendicazioni?
In premessa è bene sottolineare che il processo costituente è durato un anno. È iniziato nel 2007, poco dopo che si è installato Rafael Correa, con lo scopo di rifondare lo Stato ecuadoriano, al termine di una stagione prolungata (iniziata negli anni Ottanta) di instabilità politica e di applicazione selvaggia (benché meno intensa che in altri Paesi della regione latinoamericana) del modello neoliberista. A partire dal malessere profondo che la società sentiva nei confronti della politica (basti pensare agli slogan che hanno animato molte delle contestazioni dei primi anni Duemila: Que se vayan todos!, Basta con la partidocracia!, etc.), è maturata l’esigenza di ripensare le relazioni di potere e di avviare un processo di ristrutturazione profonda dello Stato.
L’anteriore quadro costituzionale era stato elaborato dieci anni prima, al termine di un processo completamente diverso dall’ultimo: la Costituzione del 1998, infatti, era stata discussa ed approvata in una caserma militare, a porte chiuse, senza partecipazione né grandi innovazioni. Era una Carta che riaffermava sostanzialmente l’egemonia dei partiti e dei poteri forti, delle élites economiche e politiche. Correa ha vinto nel 2007 proprio perché, cavalcando questo profondo malessere sociale, aveva promesso che come prima iniziativa avrebbe convocato l’Assemblea Costituente.
Uno degli elementi innovativi della nuova Carta consiste proprio nella “costituzionalizzazione” dei diritti, e tra essi quelli legati alla comunicazione e all’informazione. Nell’anteriore Costituzione non c’era alcun riferimento specifico a questi diritti né ai media come soggetti attivi della democrazia; in questa nuova, invece, figurano, e figurano proprio grazie al protagonismo di una serie di attori che hanno animato la fase costituente. Anzitutto il movimento indigeno, ma anche le ONG che si dedicano alla questione dei diritti legati all’informazione e alla comunicazione (ad esempio: l’Asociaciόn Latinoamericana de Informaciόn –ALAI-; l’Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica –ALER-; in parte, il CIESPAL che è un centro di produzione radiotelevisiva e di formazione in giornalismo; Radialistas Apasionadas y Apasionados che è un centro di produzione radiofonica che mira alla democratizzazione del medium dal punto di vista del genere e della partecipazione cittadina; e anche la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador -CORAPE-), le Università e gli intellettuali che anche a titolo personale tuttora contribuiscono ad intavolare e mantenere vivo il dibattito sulla comunicazione, così come gruppi di giovani che dal basso sperimentano già da anni forme alternative di informazione (ad esempio: il collettivo El Churo che gestisce e promuove eventi culturali e progetti radiofonici dal 2005).
A ben vedere, si trattava (e si tratta ancora) di un insieme abbastanza eterogeneo di persone e realtà che sentivano ormai forte l’esigenza di intervenire nell’ambito della comunicazione, e nello specifico della comunicazione mediatica. La motivazione fondamentale risiedeva nell’“anomalia” ecuadoriana, ossia nel fatto che:
-
i mezzi di comunicazione erano di natura esclusivamente privata (non esistevano quotidiani, reti televisive o radiofoniche statali, come nel Venezuela prima di Chávez);
-
era ammessa la concentrazione di più media nelle mani di un unico proprietario (i cd.dd. “conglomerati”, o grandi gruppi editoriali);
-
pochi e specifici canali tendevano a monopolizzare l’audience (la concentrazione dei pubblici).
Di fronte a questo scenario, era chiaro che bisognasse fare qualcosa: così, nella nuova Costituzione si sono introdotti ben cinque articoli dedicati alla comunicazione e informazione, nell’ambito di un testo normativo molto esteso e meticoloso (ben 444 articoli) che mirava a passare da uno Stato di diritto a uno Stato di diritti senza incorrere in ambiguità interpretative. Due sono state le grandi novità introdotte in materia: il divieto del monopolio/oligopolio nella proprietà e nella gestione dei media; il riconoscimento non solo del diritto all’accesso dell’informazione, ma anche alla sua produzione.
La vera sfida, infatti, non consiste solo nel tutelare il diritto del cittadino ad avere un’informazione contestualizzata, verificata e plurale, come già prevedono molti Trattati internazionali, ma proprio a creare le condizioni affinché più soggetti possano produrre informazione e comunicazione, senza dipendere da chi tradizionalmente è deputato a questo compito. Nell’ambito delle frequenze radiotelevisive, ad esempio, un’associazione che voglia entrare nello spazio mediatico, ha la possibilità di richiedere una frequenza (nel caso dell’analogico) o un segnale (nel caso del digitale): lo Stato è obbligato non solo a garantire un’informazione di qualità attraverso una regolamentazione adatta del settore, ma anche e soprattutto a “pluralizzare” la composizione di chi genera informazione e comunicazione. Così, i soggetti che oggi possono accedere all’etere sono tre: il settore pubblico, il settore privato e quello comunitario. Ciò può contribuire a diversificare la produzione di informazione e quindi a narrare le realtà in modi più utili per le audience.
Nel giugno 2013, al termine di un lungo processo di deliberazione che ha visto partecipi non solo il Governo e le lobby mediatiche ma anche la società civile, è stata approvata la nuova Ley de Comunicaciòn. Essa prova a dare attuazione ai principi costituzionali che ci hai descritto, disciplinando, tra le tante materie, proprio la questione dell’attribuzione delle frequenze radiotelevisive. Nello specifico, se ne assegna un terzo a ciascun settore: statale, privato e comunitario. Puoi spiegarci meglio chi sono questi media comunitari?
Il settore comunitario è proprio quello che va oltre il pubblico e il privato. È il “comune”. Non bisogna cadere nella trappola che esso includa solo le comuna, cioè le comunità indigene; loro ne fanno certamente parte, ma non solo… Ad esempio, un gruppo di giovani come quelli che lavorano a Core, che vogliono avere una testata giornalistica per svolgere attività di comunicazione, è classificabile nell’ambito dei media comunitari. Questo, almeno, è quello che è stato concepito in fase di deliberazione; poi bisogna vedere come verrà attuata la legge. Essa è stata approvata a fine giugno dello scorso anno; da un paio di mesi è stato redatto il Regolamento attuativo. Tuttavia, le vicende che hanno accalorato l’approvazione inducono a restare prudenti: all’ultimo minuto è stata emendata in molte parti, con modifiche preoccupanti.
Il processo partecipato che ha contraddistinto la fase costituente prima, e l’approvazione della nuova Ley de Comunicaciόn dopo, ha visto in prima linea la società civile, i movimenti e molti attori non istituzionali. Tuttavia, Correa e il suo partito (Alianza País) hanno usato queste spinte per la propria lotta personale nei confronti delle lobby mediatiche; così, tutte le novità introdotte con la Ley sono diventate strumentali agli interessi del Governo.
Un esempio pratico. Il settore pubblico, cui è destinato il 33% delle frequenze radiotelevisive, include anche i media di “carattere ufficiale”, afferenti a tutte le istituzioni di Governo del Paese sia a livello nazionale che locale. Tale denominazione, introdotta in extremis a ridosso dell’approvazione della Ley, cela chiari intenti politici; non a caso, quindi, il partito di maggioranza si è opposto ad una nostra proposta di limitare, – almeno nel Regolamento attuativo! – ad un terzo del 33% la quota destinata ai media ufficiali governamentali. Non essendo stata accolta tale proposta, ora il rischio è che questi monopolizzino lo spazio mediatico pubblico, a scapito delle altre entità pubbliche non statali.
Ancora: l’impostazione concettuale che era alla base della riforma in materia di comunicazione presupponeva e richiedeva l’abrogazione completa della normativa precedente, la quale, è bene ricordarlo, era stata elaborata durante la dittatura! Nella nuova Ley, sorprendentemente, non c’è menzione di questo: gli emendamenti dell’ultimo momento hanno fatto sì che si derogasse espressamente solo ad alcuni passaggi della legge precedente, ma l’impianto normativo è rimasto sostanzialmente in piedi.
La stessa divisione dell’etere in parti eguali pone non pochi problemi, giacché attualmente non vi sono frequenze disponibili per la loro redistribuzione in terzi. Nel 2009 una ricerca commissionata dall’Assemblea costituente ha ricostruito i procedimenti di assegnazione delle frequenze radiotelevisive degli ultimi quindici anni ed è emerso che circa il 64% di queste era stato concesso in modo fraudolento, peraltro anche con pratiche illegittime di subappalto. I risultati inducevano quindi a riconvertire quelle frequenze indebitamente occupate in frequenze libere e pronte alla ridistribuzione; ma non è mai accaduto a causa dei compromessi raggiunti con le forze conservatrici interne al Governo che temevano di perdere i privilegi acquisiti in decenni. Era invece importante recuperare quote di etere, restituendole allo Stato che poi le avrebbe assegnate ai tre settori, in primis ai media comunitari che lamentano tuttora una vistosa assenza nello scenario mediatico mainstream (oggi c’è solo una frequenza assegnata a una radio comunitaria!). Chiaramente, passare per lo Stato era inevitabile poiché il problema dell’Ecuador è proprio che tutto passa e si esaurisce in esso. In fase di discussione della Ley, da parte della società civile era stata avanzata la proposta di considerare collettiva la proprietà delle frequenze, vale a dire di specificare che queste fossero di tutti gli abitanti (cittadini e residenti) che vivono in Ecuador (la c.d. “titolarità diffusa”), ma il Governo si è opposto perché in questo modo mantiene indirettamente un monopolio mediatico nel dualismo con le lobby private.
Questa riforma, almeno nei suoi obiettivi e contenuti originariamente elaborati, ha preso spunto da analoghi progetti di legge implementati in altri paesi del continente?
Sì. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión venezuelana (in vigore dal marzo del 2005) ha ispirato l’impianto generale della riforma ecuadoriana; invece, l’idea della tripartizione dell’etere proviene dalla Ley de Servicios Audiovisuales argentina (promulgata nell’ottobre del 2009). Tuttavia, è bene ricordare che la riforma argentina non tratta la stampa e non stabilisce una disciplina circa i contenuti dell’informazione: regolamenta solo l’assegnazione delle frequenze per rompere gli oligopoli, come per esempio quelli che ancora oggi esercita il gruppo Clarín.
A questo proposito: nella Ley de Comunicaciòn ecuadoriana come vengono considerati i quotidiani? Più in generale, puoi descriverci brevemente come funziona l’ecosistema mediale ecuadoriano, con riferimento ai media tradizionali e digitali?
Dal punto di vista della disciplina formale, la nuova Ley introduce una serie di elementi che però ad oggi sono ancora inattuati.
I quotidiani, al pari di tutti i media, devono anzitutto registrarsi presso il Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, dichiarando di essere dotati di uno Statuto etico e pubblicando chi sono i proprietari e il pacchetto associativo. Inoltre, sono regolati nei contenuti dai primi articoli della Ley che definiscono proprio ciò che dovrebbe essere un medium (i cc.dd. “principi deontologici”).
Tuttavia, la tripartizione in settore pubblico, privato e comunitario non è prevista anche per la carta stampata. Essa vale solo per le frequenze radiotelevisive. Quindi un collettivo che volesse aprire una testata giornalistica verrebbe considerato come privato e non avrebbe nessun appoggio, come invece accade nel caso della richiesta di assegnazione di una frequenza.
A proposito di appoggi: sono previsti dei finanziamenti pubblici in favore dell’editoria privata e, quindi, anche dei media comunitari?
Formalmente non esisteva e non esiste alcun tipo di finanziamento. Tuttavia, ci sono stati dei meccanismi che andavano in questa direzione. Ad esempio: la carta che si usava per stampare i quotidiani era IVA esente; poi Correa l’ha tassata per equipararla alla carta con cui si stampavano i libri. Più in generale, ci sono state leggi, alcune delle quali ancora vigenti, che hanno agevolato i media in termini di piccole prebende.
Un’ultima domanda. Questa riforma ha innovato l’intero sistema dell’informazione mainstream nell’ambito di un Paese in cui i media tradizionali (stampa, tv e radio) ancora rivestono un ruolo centrale nella formazione dell’opinione pubblica. Che prospettive ci sono allora per i media digitali e l’informazione sul web?
Pochissime, purtroppo. Ho l’impressione che il Governo, quindi lo Stato, farà di tutto per ostacolare l’ascesa del settore comunitario che notoriamente è proprio quello che sfrutta maggiormente la comunicazione on line e le potenzialità delle tecnologie digitali. Abbiamo già osservato da vicino come il Governo assegni al settore comunitario frequenze solo laddove le varie realtà si dimostrino fedeli ad Alianza País. La società civile è ormai schiacciata sulleposizioni ufficiali.
Tuttavia non voglio essere estremamente pessimista: resta il fatto che la Ley garantisce molti diritti e introduce innovazioni interessanti. Potenzialmente il settore comunitario può appropriarsi degli spazi riconosciuti dalla Ley. È quindi necessario prevedere dei meccanismi di sostegno anche economico per facilitarlo; altrimenti, anche se in ipotesi vi fossero frequenze disponibili, senza finanziamenti come potrebbe presentare un progetto idoneo (capacità tecnica, finanziaria, di gestione, etc.) e “vincere” così l’assegnazione della frequenza? Nella Ley si prevede che lo Stato possa agevolare i media comunitari con prestiti a interessi blandi; bisognerà vedere però se nel Regolamento attuativo verrà disciplinato e regolamentato adeguatamente questo punto che è dirimente; altrimenti potrebbe capitare che una comunità indigena o un gruppo di giovani, pur essendo capace di mettere in piedi un progetto valido, non sarebbe economicamente in grado di dotarsi delle apparecchiature necessarie a svilupparlo.